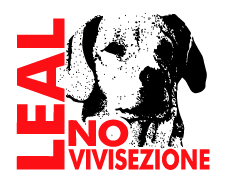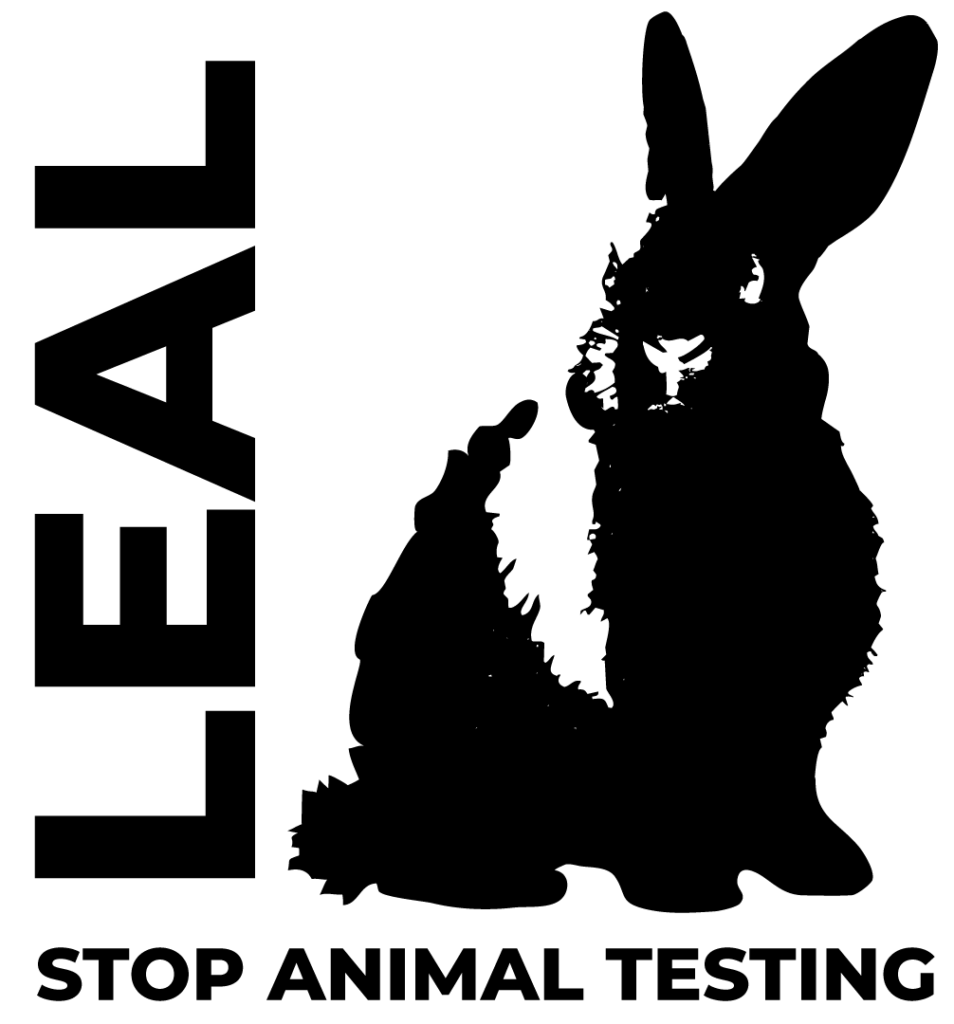da Redazione Leal | Dic 5, 2022 | LEAL informa, Vivisezione
Manuela CassottaBiologa, medical writer Con la recentissima pubblicazione del report “metodi non-animali avanzati per lo studio delle malattie autoimmuni”, la serie di raccolte “Metodi avanzati non-animali per la ricerca biomedica” pubblicata dal Centro Comune di...

da Redazione Leal | Set 2, 2022 | Vivisezione
La principale giustificazione alla base dell’utilizzo degli organismi modello è che questi hanno in comune con noi un’alta percentuale di geni. E’ vero che i topi condividono con noi circa il 90% dei geni. Ma ciò è veramente sufficiente a giustificare l’utilizzo di...

da Redazione | Lug 8, 2022 | LEAL informa, Vivere eticamente, Vivisezione
Siamo oggi di fronte all’evidenza che la ricerca basata su modelli animali non costituisce un problema soltanto di ordine etico-animalista ma anche scientifico e metodologico. Sempre più studi pubblicati su riviste scientifiche internazionali mettono infatti in...

da Redazione Leal | Giu 20, 2022 | Vivisezione
Manuela Cassotta Biologa, medical writer Tra gli animali più utilizzati per studiare il sistema immunitario e testare gli effetti dei vaccini vi sono i topi, i furetti, e i primati non umani. Sebbene questi animali riescano a riprodurre in parte alcune caratteristiche...

da Redazione Leal | Giu 6, 2022 | LEAL informa
Manuela Cassotta Biologa, Medical Writer In seguito ad un divieto iniziale dei test cosmetici su animali per alcuni endpoint per i prodotti finiti (2004) e per gli ingredienti (2009), nel 2013 l’UE aveva attuato il divieto di tutti i test sugli animali per...

da Redazione Leal | Apr 15, 2022 | Vivisezione
Manuela Cassotta, biologaMedical writer Il morbo di Parkinson è una condizione neurodegenerativa complessa con un’origine multifattoriale. Ad oggi, gli approcci alla scoperta di farmaci per il Parkinson hanno portato a terapie sintomatiche per le manifestazioni...

da Redazione Leal | Mar 5, 2022 | Vivisezione
Manuela Cassotta, Biologa, Medical writer Il ragionamento scientifico alla base della sperimentazione animale è che un animale sia una buona rappresentazione e quindi un modello di un essere umano, e che sta agli scienziati interpretare nella giusta maniera quello...
da Redazione Leal | Feb 12, 2022 | Vivisezione
La verità e la sofferenza dietro i numeri e le parole. Sono state recentemente pubblicate le statistiche relative all’utilizzo di animali utilizzati per fini sperimentali nel 2018 in Italia (Gazzetta Ufficiale n.26 del 01-02-2022). Manuela CassottaBiologa, Medical...