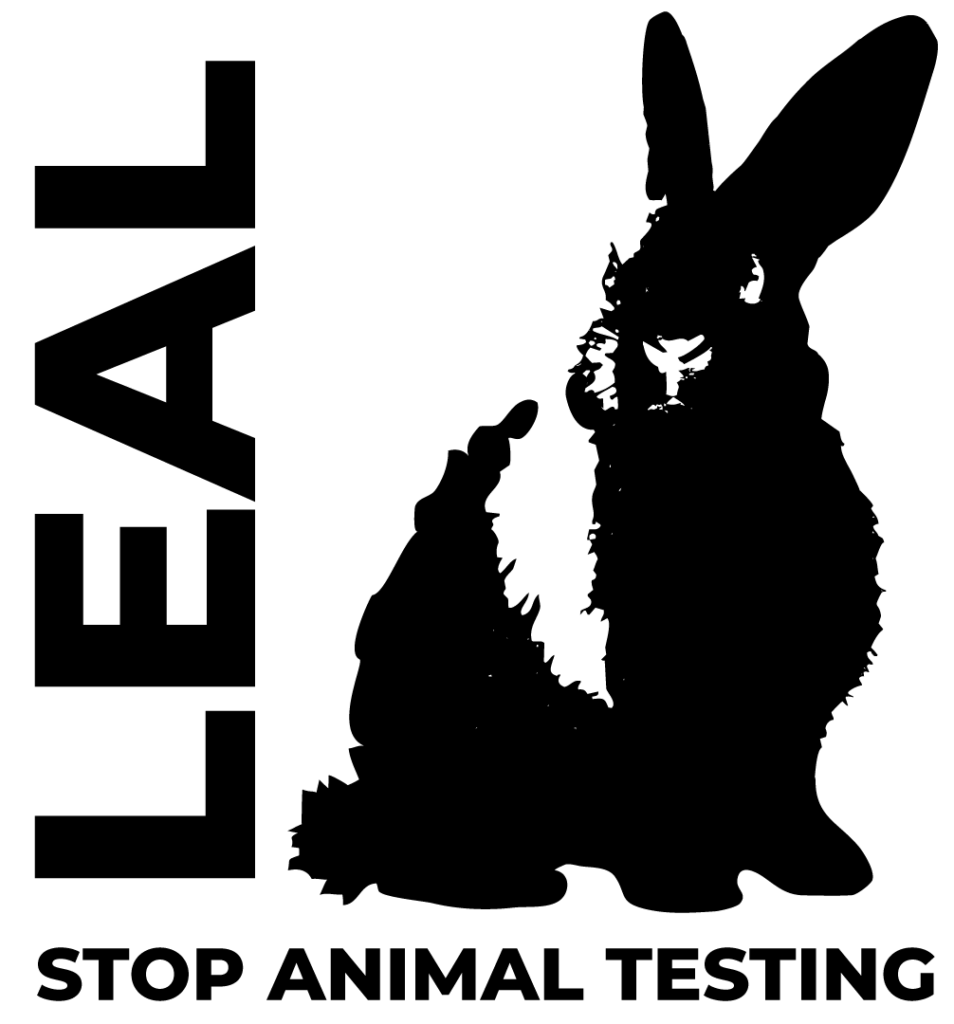Una recente notizia, secondo cui il Ministro federale dell’occupazione canadese, Maryann Mihychuck, starebbe pensando di assumere rifugiati siriani nei macelli della federazione, è una di quelle che apre orizzonti di pensiero: non è cosa di poco conto, infatti, che, a fronte dei numeri di una crescente disoccupazione, i cittadini del paese siano disposti a rifiutare uno stipendio, quando comporta andare ad uccidere di persona vitelli, pecore e maiali e lavorarne le carni.
È l’ennesima occasione per alzare il velo su quella realtà negata e offuscata in tutto il mondo occidentale che è quella dei macelli. Realtà rimossa e nascosta dal punto di vista fisico e della sua stessa esistenza, se è vero che, nonostante l’immenso numero di animali quotidianamente mangiati (dati Fao non aggiornati) parlano di 56 miliardi di animali terrestri uccisi ogni anno), i luoghi della loro uccisione sono molto spesso ignoti: non ne conosciamo la dislocazione e tanto meno sappiamo cosa veramente abbia luogo al loro interno. Ne intravediamo la realtà visto che ci capita di incontrare su strade e autostrade camion stipati di vitelli, mucche, maiali, cavalli: incrociamo persino il loro sguardo attraverso le barre che li imprigionano e ne sentiamo i lamenti se ci capita la malaugurata sorte di fermarci in una piazzola dove anche il loro autista si è preso una sosta. Imbarazzante allora camminare vicino a loro e cogliere l’orrore in atto nel rapido sguardo che gettiamo prima di girare di scatto la testa dall’altra parte, perché non ce la facciamo proprio ad osservarli ancora. E se l’estate è torrida o l’inverno gelido, i lamenti che udiamo sono strazianti non solo di sete e stanchezza. Da qualche parte, dobbiamo pur dircelo, stanno andando e dove se non ad essere ammazzati? Ma dove sia il posto in genere lo ignoriamo.

Niente è per caso, tanto meno il fatto che i macelli siano situati non solo lontano dai centri abitati, ma anche in luoghi indefiniti, non indicati, difficilmente identificabili. Luoghi dove per altro è vietato entrare come comuni cittadini a guardare cosa vi succede: DIVIETO D’ACCESSO; tanto più è vietato fare uscire fotografie e filmati; addirittura in alcuni stati americani è proibito registrare i rumori, i suoni, se così è possibile chiamare le urla degli animali a un passo dalla morte. Il perché di tanta preoccupazione a non far sapere risulta chiaro quando si guardano i video clandestini, frutto di inchieste altrettanto clandestine, vere e proprie cartoline dall’inferno; e quando si leggono resoconti di operai che vi lavorano o di giornalisti infiltrati. Ne conosciamo bene anche i particolari quando scoppia uno scandalo e i giornali si riempiono di titoli emotivamente carichi che parlano di “macello degli orrori”, “crudeltà nei mattatoi” “azienda fuorilegge nella fabbrica della carne”. A quel punto vi è grande dovizia di particolari, perché ci si sente nei panni del censore, del salvatore, di chi coraggiosamente denuncia. Peccato che invece si stia parlando della norma, che invece, in quanto tale, non viene denunciata con altrettanto vigore, perché comporterebbe una presa di posizione, questa sì davvero coraggiosa, contro tutto un sistema e qui si fa il vuoto, giornalistico e non.
Il sistema di occultamento della realtà che comporta la dislocazione dei macelli in luoghi sconosciuti o inaccessibili e il tentativo di black out della relativa informazione, è in funzione di una innegabile sensibilità che, nel mondo occidentale, si va sempre più diffondendo e coinvolge in ugual modo le violenze su uomini e animali: in un tempo neppure tanto lontano, che si misura in qualche secolo, la pubblica piazza era il luogo delle esecuzioni, dei tormenti punitivi, della gogna: l’apoteosi della ghigliottina che celebrava la rivoluzione francese mozzando teste davanti a donne che sferruzzavano e a monelli che facevano il tifo ne è un fulgido esempio. Prima che ragioni sanitarie inducessero a spostare i macelli in periferia, gli animali venivano quotidianamente sgozzati anche nelle strade delle città, dove nugoli di ragazzini assistevano e imparavano l’indifferenza o, ancor peggio, l’identificazione facile con il più forte, finendo per infierire ulteriormente, per gioco, sulla vittima indifesa, esattamente come la folla in genere si accaniva sul reo sottoposto al pubblico ludibrio. Un inarrestabile percorso verso il superamento delle forme inaccettabili di prepotenza e crudeltà, ha portato a rinnegare l’orgoglio un tempo incredibilmente connesso all’ostentazione della violenza, che era un modo per affermare il proprio potere. Di certo molte cose sono cambiate in modo sostanziale per quanto riguarda gli umani, per esempio con la progressiva abolizione della pena di morte (nel mondo occidentale ancora oggi ammessa in Bielorussia, unico stato in Europa, Stati Uniti, Giappone…). Delle forme che sopravvivono ci si vergogna, non sono certo politicamente corrette e quindi vengono bene occultate, requisito fondamentale alla loro negazione: è il caso per esempio della tortura (per inciso, l’Italia ancora non si è data una legge al riguardo), che ripetuti casi di cronaca ci dicono ancora viva e vegeta all’interno delle istituzioni carcerarie, e in realtà di degrado ancora sussistenti nei luoghi dove gli ultimi degli ultimi vengono reclusi: orribili istituti quali i manicomi criminali, la cui chiusura è giusto dei mesi scorsi, per fare un esempio.
Qualcosa di molto simile riguarda gli animali, i quali, “quelli da carne” in primo luogo, sono lontanissimi dal godere del riconoscimento dei diritti reali, di cui, almeno sulla carta, gli umani godono. Macellare si può, non solo non è reato, ma è il fondamento stesso della nostra attuale quotidiana alimentazione; ma davvero non è bello da vedere e quindi la strada maestra diventa quella di oscurare Nascondere questa realtà, e le tante altre dello stesso genere, è un’operazione comunque gravida di conseguenze: quanto più la crudeltà, in tutte le sue forme, contro umani e contro animali, viene occultata tanto più viene a mancare il processo di desensibilizzazione che accompagna l’abitudine alla crudeltà stessa: certe manifestazioni non entrano nel nostro quotidiano, nella verità esperienziale, nel nostro patrimonio comportamentale, con il risultato che quando ne veniamo in contatto mostriamo tutta la nostra vulnerabilità: gli spettacoli che un tempo venivano vissuti come normali suscitano allora immediate reazioni di sconcerto, rifiuto, raccapriccio. La spirale sia attorciglia: tanto più siamo disabituati alla crudeltà tanto più acuiamo la nostra sensibilità verso tante forme di sofferenza tanto più abbiamo reazioni di rifiuto quando ne veniamo in contatto. Il problema è che, anime belle e sensibili quali siamo progressivamente diventate, ci commuoviamo davanti agli animali, ma di certo non fino al punto da astenerci dal mangiarli, anzi: i numeri sono diventati stratosferici, le modalità quelle della catena di montaggio, dove il massacro viene industrializzato, con i ritmi e l’organizzazione inevitabilmente osceni che lo definiscono. Uno straordinario reportage di Timothy Pachirat, assistente di scienze Politiche presso la Amherst University del Massachussetts, che lavorò per molti mesi sotto mentite spoglie come operaio in macelli americani, riporta che la norma è l’uccisione di un animale ogni 12 secondi (“Every twelve second” è il titolo del suo libro, edito dalla Yale University Press).
Inutile sottolineare la nostra schizofrenia: anche in tempi in cui i numeri degli animali uccisi erano infinitamente inferiori, gli uomini, gli stessi che si nutrivano senza remissione di ogni genere di animale, non ne hanno mai tanto gradito l’uccisione: non è un caso se quello del macellatore è sempre stato un lavoro destinato alle fasce più povere, ai senza diritti: Plutarco[1] condannava caccia e macellazione in quanto fonte di insensibilità e causa di danno sociale. Tommaso Moro[2] sosteneva che la macellazione dovesse essere affidata a schiavi, in quanto tali destinati ai lavori più sporchi. In India è sempre stata la classe dei paria (abolita nelle leggi, ma non nei fatti) ad occuparsene. Oggi le cose non sono tanto diverse: negli Stati Uniti a lavorare nei macelli sono soprattutto immigrati clandestini, molti provenienti dalla frontiera messicana, vale a dire persone in situazioni di tale emarginazione e precarietà da non potersi permettere il lusso di scegliere alcunché, tanto meno il lavoro. È in questo scenario che trova collocazione la notizia di apertura: il civilissimo Canada, paese di grandi spazi e sviluppata cultura, come pensa di assicurare alla gente la sua bistecca quotidiana, il prosciutto o l’agnello? Semplice: c’è sempre chi non può dire di no e l’ondata migratoria, con il suo carico di tragedie, offre la manodopera ideale, disperata, in fuga da altri massacri, impossibilitata a scegliere: i siriani. Davvero niente di nuovo sotto il sole, quando si parla di privilegi e di sottomissioni, di ingiustizie che si infiltrano dovunque.
Ma “Qual è il prezzo che questo genere di attività può rappresentare per persone già traumatizzate dalla guerra? Quale tipo di benvenuto può dare con un affare tanto cruento un paese che dovrebbe rappresentare una chance luminosa e splendente di felicità”: domanda retorica, quella che si pone la giornalista Susan Bird[3]. All’interno dei mattatoi l’oscenità in atto vede sangue, disperazione, dolore e morte di esseri terrorizzati e indifesi. Come si può pensare che chi in prima persona è chiamato a esserne l’aguzzino, l’esecutore materiale, possa svolgere questo “lavoro” con compostezza e garbo, lavoro che, pure regolamentato da leggi di tutela del benessere animale, in Europa prevede per gli operatori certificazioni di idoneità a stordimento, immobilizzazione, enervazione, elettrocuzione, dissanguamento? A ritmo continuo. È parte integrante del clima di efferatezza l’essere, o il diventare, efferati: perché il lavoro stesso è opera cruenta e feroce, ma anche perché la psiche non può mantenersi indenne in mezzo a tutto questo e devono entrare in azioni meccanismi tali da rendere sopportabile l’insopportabile. Bisogna convincersi che quegli animali strattonati, feriti, inermi, terrorizzati non siano le vittime innocenti che in realtà sono: il pensarlo inibirebbe l’azione. Bisogna invece credere che siano esseri spregevoli, immondi, che meritano ciò che stanno subendo e che, quando con comportamenti di recalcitrante ribellione o solo di disperata resistenza rendono il lavoro del macellaio più duro, debbono essere ulteriormente puniti. Tutte le cronache dei macelli testimoniano questa verità: ovunque, non in “casi isolati” o nei “macelli della vergogna”, vengono compiuti atti la cui nefandezza travalica la necessità dell’uccisione: gli animali vengono ulteriormente seviziati, in un crescendo di crudeltà che non conosce limiti. Per altro si tratta di lavori estremamente duri anche a livello fisico, pericolosi, sottopagati, parcellizzati: elementi tutti che concorrono alla durezza del clima, delle condizioni di vita, delle relazioni.
In tutti i territori di violenza si riscontrano dinamiche simili: negli scenari delle guerre, nei campi di sterminio di ogni latitudine ed ideologia, nelle carceri più dure: bisogna salvare se stessi a scapito della vittima; infierire su di lei presuppone che non ci si possa fare carico della sua sofferenza, ma che anzi questa venga negata contestualmente alla sua svalutazione: merita quello che le viene fatto, non vale nulla, è qui per questo e quindi ucciderla o seviziarla non può essere fonte di colpa. Il male accessorio è lì a dimostrare tutto questo e gli epiteti con cui le bestie vengono regolarmente insultate ne sono la prova verbale. Non necessariamente entrano nei macelli uomini brutali, ma sono molti a uscirne tali. Esattamente come non sono brutali tutti i ragazzi (e ragazzini!) mandati a combattere, ma di certo la guerra non rende gentili. Il nome di My Lay, poverissimo villaggio vietnamita dove giovanottoni americani in assetto di guerra uccisero, seviziarono, bruciarono vivi piccoli uomini e donne scalzi e indifesi, è solo uno di quelli divenuti famosi in virtù di un processo dalla risonanza mondiale che ne seguì, per altro conclusosi con condanne irrisorie. E delle violenze gratuite che ebbero come scenario Abu Graib, il ricordo è più che mai vivo. Quanto faticoso sia per molti convivere con la quotidianità dello sfacelo lo dimostra l’alto tasso di alcolismo che si registra in molte delle comunità che vivono sui macelli, non diversamente da quanto spesso avviene in guerra, o nei “piani di eliminazione” di vario genere e tempo[4] o nell’abuso di droghe che segna la vita di tanti veterani: misero conforto per ogni vittima. Addirittura si parla oggi di un tipo particolare di stress post-traumatico, indotto dall’essere non vittima, ma partecipante attivo di un evento traumatico: i sintomi includono depressione, dissociazione, paranoia, ansietà, panico, abuso di alcool e pensieri di violenza. E a volte la violenza viene diretta contro mogli e figli[5], secondo lo schema ben conosciuto di spostamento di frustrazioni e aggressività verso soggetti deboli. All’interno di questi scenari si inserisce la protesta di Nick Taylor, sociologa australiana, al programma “Sentenced to a job” del governo del Territorio del Nord del continente australiano di inserimento di detenuti per un lavoro nel mattatoio, in vista (sigh!) del loro reinserimento sociale: vi si oppone strenuamente definendo i mattatoi luoghi di ambiguità morale, psicologicamente dannosi, perché lì si chiede alle persone di togliere la vita ad esseri senzienti.
Insomma: l’Ombra esiste in ciascuno di noi: ci sono luoghi che la fanno esplodere, che sollecitano le nostre parti più oscure, parti che spesso sono lì semiaddormentate. I macelli sono tra questi, perché sono istituzioni produttive di atrocità: chi vi entra non può non commetterne. Il confine tra carnefici e vittime, lo abbiamo bene imparato da Primo Levi[6], e da tanti altri dopo di lui, Zimbardo[7] in testa, è estremamente labile: se non vi è dubbio che gli animali paghino colpe mai commesse, gli esecutori che agiscono da carnefici sono prima vittime dell’impossibilità a sottrarsi ad un compito che inevitabilmente li renderà più brutali. Di questo non possiamo non essere consapevoli e ne portiamo la colpa nella misura in cui affidiamo loro il lavoro sporco di cui siamo i pacifici e sereni utilizzatori, sempre serenamente inconsapevoli del dietro le quinte. “Se non potete eliminare l’ingiustizia, almeno raccontatela a tutti” dice Shirin Ebadi, premio Nobel per la Pace nel 2003, riferendosi alle oscene ingiustizie che hanno luogo nella sua terra, l’Iran: tutti devono sapere, bisogna parlare, denunciare, raccontare. Se non sarà sufficiente, almeno impedirà che il male, con il quale conviviamo, e di cui, con i nostri comportamenti, siamo innegabilmente complici, non lasci traccia.
L’argomento è trattato diffusamente in “Sulla cattiva strada” Ed. Sonda 2014.
[1] Filosofo greco vissuto nel I secolo d.C.: “Dialogo sull’intelligenza degli animali”.
[2] Umanista inglese vissuto tra il XV e il XVI secolo.
[3] Care2: “Slaughterhouse work is so horrible, Canada can’t find anyone to do it”, 19.01.2016.
[4] Gitta Sereny, “Dentro quelle tenebre, Gli Adelphi 1990”, ricorda l’abuso di alcool da parte degli incaricati all’eliminazione di persone minorate negli anni del nazismo.
[5] Intervista di Gail Eisnitz, autore di “Slaughterhouse: la storia scioccante di un trattamento dimenticato e inumano all’interno dell’industria della carne americana”, al Vegnews magazine.
[6] “I sommersi e i salvati”, Primo Levi, Einaudi 1986.
[7] “L’effetto Lucifero”, Raffaello Cortina Editore 2007.

www.annamariamanzoni.it
psicologa e scrittrice