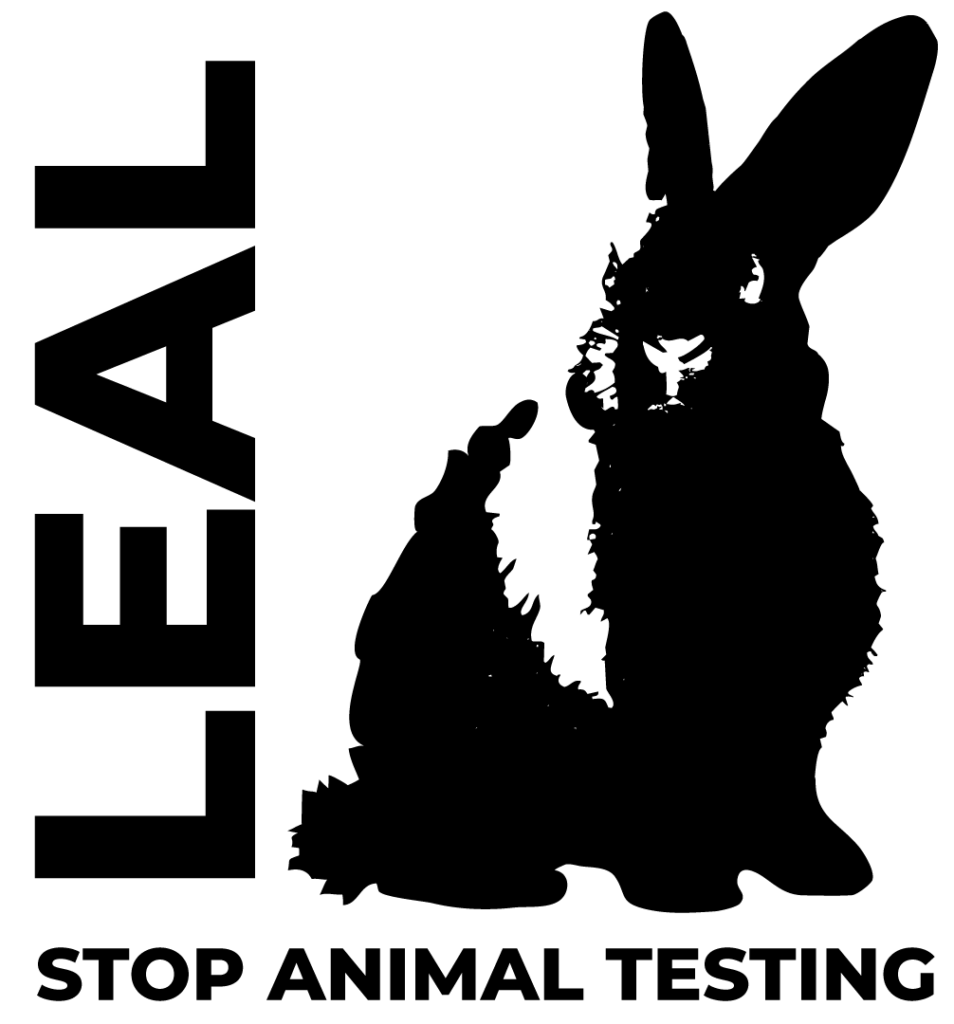“La barbarie più inumana”, “La più grave questione dell’umanità”: così definisce la vivisezione, nella seconda metà del 1800, Richard Wagner nella sua “Lettera aperta al signor Ernst von Weber”. Oltre un secolo e mezzo più tardi le stesse definizioni conservano tutto il loro senso e la loro pregnanza; da allora le cose sono cambiate solo dal punto di vista formale, in sintonia con lo spirito della civiltà occidentale che, in merito ai delitti contro gli animali, e non solo, ha messo in atto una enorme azione di occultamento e di allontanamento dalla vista e dalle coscienze, rimuovendo tutto quanto può turbare la sensibilità umana, metro e misura del lecito e dell’illecito.
 Lontani sono infatti i tempi in cui la vivisezione veniva addirittura praticata alla luce del sole: si era nella Londra della seconda metà del 1600 e la Royal Society poteva agire, forte degli enunciati di Cartesio che, identificando l’essenza degli animali nel loro essere macchine e automi, avevano dato licenza di infliggere loro i peggiori tormenti. A testimonianza che qualunque pratica necessita di un contenitore di pensiero che la giustifichi e la renda possibile. Allora i terribili esperimenti erano resi pubblici e le relative illustrazioni venivano poste accanto a quelle di decorazioni delicate e gentili, ad asserire anche graficamente non esservi alcun contrasto tra immagini di sangue e di indicibile crudeltà sugli animali e deliziosi ornamenti: l’autorità di chi li proponeva ne sdoganava serenamente la compatibilità.
Lontani sono infatti i tempi in cui la vivisezione veniva addirittura praticata alla luce del sole: si era nella Londra della seconda metà del 1600 e la Royal Society poteva agire, forte degli enunciati di Cartesio che, identificando l’essenza degli animali nel loro essere macchine e automi, avevano dato licenza di infliggere loro i peggiori tormenti. A testimonianza che qualunque pratica necessita di un contenitore di pensiero che la giustifichi e la renda possibile. Allora i terribili esperimenti erano resi pubblici e le relative illustrazioni venivano poste accanto a quelle di decorazioni delicate e gentili, ad asserire anche graficamente non esservi alcun contrasto tra immagini di sangue e di indicibile crudeltà sugli animali e deliziosi ornamenti: l’autorità di chi li proponeva ne sdoganava serenamente la compatibilità.
Oggi no, oggi non si fa più così: non sta bene e non è politicamente corretto. Di vivisezione la gente comune sarebbe anzi meglio non sapesse nulla, e questo sarebbe possibile se non fosse per il clamore suscitato da un dibattito, che, soprattutto da Hans Ruesch in poi, non ha potuto essere tacitato, ma che sarebbe rimasto contenuto nelle stanze dove le elite parlano di scienza se non fosse per la mobilitazione di tutti coloro che, in nome del rispetto dovuto agli animali, hanno rotto il muro del silenzio, spostando la questione dal piano scientifico a quello etico che tutti ci riguarda e su cui tutti abbiamo diritto, dovere di opinione, e alle coscienze della gente mostrano scimmie crocefisse, gatti ustionati, file di conigli immobilizzati con gli occhi infettati, e via proseguendo in quella galleria degli orrori che si nutre di una creativa capacità di ideare ipotesi, le più disparate possibile, e poi di mettersi alacremente al lavoro per verificarle. Così il dr. Michael Merzenich volendo sapere (1991) quali “ristrutturazioni dei processi rappresentazionali in regioni cerebrali specifiche” siano indotte da “alterazioni che provengono dall’ambiente, come quelle che derivano dall’amputazione di un arto”, diligentemente procede ad amputare per l’appunto arti ai primati che sono a sua disposizione nel laboratorio di San Francisco in cui lui esercita la sua professione. Giusto per scoprire che “anche negli adulti il cervello sembra quindi capace, entro certi limiti, di rispondere a nuove esperienze con un ulteriore sviluppo di strutture e funzioni” (“La mente relazionale”, Daniel J. Siegel, Raffaello Cortina Editore). Mentre il farmacologo irlandese John Cyran separa i cuccioli di ratto dalle madri “provocando negli animali un forte stress” (ah, ma allora i ratti provano affetto, creano legami filiali, sperimentano sofferenza psicologica nella separazione?!) valutando la loro conseguente depressione con il fatto che “se collocati in una vasca d’acqua, rimangono a galla meno a lungo degli animali di controllo non stressati”. E via imperversando fino alla conclusione, tutto fuorché originale, che “tuttavia i topi non sono persone e dunque la possibilità di trasferire all’uomo questi risultati resta ancora da dimostrare” (“Mente e cervello”, agosto 2012).
Non c’è che dire: l’uomo è curioso, intelligente, vuole sapere e varcare i confini; l’uomo è prepotente, arrogante, egoista e la crudeltà di cui è capace è pari solo alla genialità della sua mente. L’uomo, e la donna solo un po’ più nelle retrovie, occidentali hanno fatto coincidere il processo di civilizzazione con un progressivo nascondimento delle manifestazioni di malvagità che hanno accompagnato tutto il percorso evolutivo, ma che ci piace attribuire a una animalità da cui sempre più prendiamo le distanze: ci siamo ripuliti, educati, abbiamo imparato le buone maniere e aborrito le manifestazioni di brutalità. Nel tragitto i comportamenti di sfrenata crudeltà hanno perso visibilità e liceità, ma, lungi dallo scomparire, hanno anzi ampliato a dismisura il numero di vittime su cui accanirsi: nello specifico, la sperimentazione animale, nella nostra attuale società tanto amante degli animali, coinvolge ogni specie per ogni scopo, che sia medico o psicologico, che serva a testare cosmetici o al bisogno evidentemente ineludibile di un nuovo detersivo, che sia finalizzata a soddisfare curiosità fantasiose oppure permetta una pubblicazione la cui utilità, oggettivamente opinabile, appare in tutta la sua pregnanza se valutata ai fini del punteggio per un futuro concorso.
Non c’è da meravigliarsi: il confine fittizio e utilitaristico tra umano e animale, una volta superato, immette nel regno del tutto possibile. Gli animali sono al nostro completo servizio e ciò si traduce dal punto di vista alimentare nella licenza di ucciderne miliardi ogni anno; dal punto di vista della sperimentazione nel non farsi mancare nulla: si sperimenta in vista di una presunta necessità per la salute umana, o di qualcosa che forse, chissà, potrebbe anche rivelarsi importante in futuro, per stabilire le conseguenze dello spazio di frenata dell’automobile, o perché gli studenti apprendano i necessari rudimenti medici dalla viva carne, che è molto meglio. Dove fermarsi? Perché farlo? Un acceso sostenitore della sperimentazione animale (che, per ragioni sconosciute, si firma solo MB), lo chiarisce molto bene in un sito ad hoc; “In difesa della sperimentazione animale”, quando sostiene che la conoscenza scientifica fine a se stessa, l’amore per il sapere sono l’uso più Nobile (la maiuscola è sua) che l’uomo possa fare degli animali: in altri termini, gli unici limiti sono quelli stabiliti dalla possibilità di ideazione, che contiene quella di possibili aberrazioni, della mente umana. E si tratta di confini del tutto leciti, al contrario di altri che pure esistono all’interno della specie umana, dove i più derelitti, poveri, esclusi dai diritti di fatto sono sempre stati utilizzati in forme di “sperimentazione”: i medici nazisti hanno potuto imperversare indisturbati grazie al materiale umano di cui potevano servirsi a piacimento; i manicomi, come luoghi chiusi che escludono dal consesso civile chi non è all’altezza, non hanno ancora finito di darci notizia di tutte le nefandezze praticate al loro interno; la pratica della tortura, in molti paesi del mondo del tutto attuale, sperimenta i limiti e la sopportazione umana al dolore.
Nonostante il grande lassismo della morale, tutto ciò non è però politicamente corretto: la sperimentazione sugli animali sì. La giustificazione morale degli obiettivi da perseguire non solo sdogana ogni pratica sugli animali: fa di più, la rende invisibile. Per analogia risulta interessantissima, in merito a questa dinamica, la ricostruzione che Vittorino Andreoli, stimatissimo psichiatra, fa della sua carriera di medico, ricordando la propria impassibilità quando a venti anni, brillante studente e fervente cattolico, si trovò per la prima volta davanti all’orrore dei manicomi, dove esseri umani potevano essere tenuti per mesi o anni legati ai letti, abbandonati nei propri escrementi, o “terapeuticamente” obbligati a docce gelate. Solo oggi arriva a chiedersi: “Come è accaduto che non solo io, ma uomini di grande levatura morale potessero accettare tutto questo? Come ho potuto non provare un moto di ribellione di fronte a tanto degrado? Dove trova la sua ragion d’essere una simile anestesia dell’uomo nei confronti della sofferenza di altri uomini?… Credo che a legittimare la nostra insensibilità, a darle un sostegno, fossero una serie di convinzioni, di razionalizzazioni”. (“I miei matti”, Vittorino Andreoli, Rizzoli Editore). Evidentemente le stesse convinzioni e razionalizzazioni, che consentono ancora oggi a tante persone di assistere o di provocare personalmente, anestetizzate e senza sensi di colpa, inaudite sofferenze agli animali nei laboratori di vivisezione, dove la violenza è normalizzata (perché è normale che nuove sostanze o tecniche siano sperimentate), giustificata (perché è necessaria), negata (perché gli animali, si sostiene, non soffrono, essendo trattati con rispetto).
Esistono potenti meccanismi nella mente umana al servizio del nostro benessere: sanno fornirci una narrazione dei fatti tale da consentirci di convivere con sufficiente tranquillità con noi stessi, senza il peso di troppe angustie, quali che siano (state) le nostre azioni: il delitto senza castigo, neppure quello psichico, è quello che prediligiamo.
Per concludere l’analogia con il mondo dei manicomi, vale ancora la pena di ricordare che un altro medico vi mise piede, alcuni anni dopo Andreoli, e vide ciò che generazioni di psichiatri prima di lui avevano visto e accettato come normale: ma lui quella violenza su esseri deboli non la scambiò per pratica terapeutica necessaria: la valutò come inaccettabile abuso, vide il dolore di individui sfiancati non tanto dalla malattia quanto da altri individui in camice bianco, e rifiutò di esserne complice. Era Franco Basaglia: nel 1978 la legge che porta il suo nome decretò per sempre la chiusura dei manicomi.
Allo stesso modo, anche per quanto concerne la vivisezione, non va sottaciuto il peso del comportamento dei singoli, ognuno dei quali ha una precisa responsabilità personale in quello che decide di fare e in quello che si astiene dal fare: in altri termini, con le parole del sociologo Zigmunt Bauman, l’ingiustizia è negligenza individuale. Per altro il dibattito attuale, la definizione quale Falsa Scienza da parte della prestigiosa rivista Nature, la revisione in atto consentono di assumere posizioni critiche, di rifiuto dello status quo anche senza attitudini eroiche e pur in mancanza di quel coraggio che se uno non ce l’ha, non se lo può dare; d’altro canto, chi decide di praticarla deve riconoscersi portatore di una scelta precisa. Esiste quindi il peso specifico della responsabilità che ogni singolo si assume, peso tanto maggiore visto che si tratta di un campo in cui non sono neppure invadenti altre spinte, che di fatto vanificano la libertà personale, quali quella economica: a differenza di quanto si verifica nel raccapricciante mondo dei macelli a catena di montaggio, popolato da immigrati costretti a scelte obbligate, il mondo degli sperimentatori scientifici gode di un livello culturale e di conseguenza socioeconomico spesso privilegiato.
Tutto questo considerato, riveste notevole interesse conoscere l’atteggiamento emotivo di coloro che, consapevolmente, optano per questa strada, che comporta la necessità di fronteggiare l’inenarrabile dolore inflitto nella carne viva di vittime, immobilizzate sui tavoli, quelle che guardano terrorizzate ogni loro movimento nell’attesa insopportabile del prossimo gesto, quelle che supplicano pietà perché non hanno commesso colpe, quelle che lasciano solo intuire i propri gemiti perché le corde vocali sono state tagliate, quelle che possono chiedere grazia solo a chi è il responsabile del loro martirio, esattamente come accade alle vittime della tortura di ogni dittatura, di ogni scellerato aguzzino. Cosa provano i vivisettori nel guardare questi animali disperati, terrorizzati, impazziti dal dolore e dalla paura? Non sono domande da poco conto, perché all’interno del macrosistema, sono i singoli individui a consentirne il funzionamento: se il grande contenitore della vivisezione è costituito dalle convinzioni esistenziali, filosofiche, religiose che vedono nel mondo degli altri animali il magazzino inesauribile di materia prima, se sono gli enormi interessi economici coinvolti, a fare inizio da quelli delle società farmaceutiche, il motore primo di tutto il meccanismo, nulla succederebbe senza la disponibilità al lavoro sporco.
Non sembrano esistere studi specifici che illuminino sulla personalità dei vivisettori, sui tratti di base e sugli eventuali mutamenti indotti dalla reiterazione di condotte connotate dalla abitudine ad infliggere tormenti ad esseri senzienti. Non sono d’altra parte illuminanti le dichiarazioni dei diretti interessati che usano normalmente risolvere la questione appellandosi al rispetto (?!) con cui gli animali vengono trattati nei laboratori, una sorta di mantra che scansa l’invito ad interrogarsi sulle proprie reazioni umane ed emotive. Quali sono queste reazioni? La presunzione di essere al servizio dell’umanità è di tale potenza da oscurare qualunque altro sentire? Sono lecite solo ipotesi: nelle pubblicazioni scientifiche, anche la descrizione delle peggiori pratiche che invadono la carne degli animali, documentate da fotografie inguardabili da un essere umano di media sensibilità, è condotta con un linguaggio asettico, esente da qualsivoglia compartecipazione, si tratti di piccoli di scimmia con gli occhi cuciti, di gatti con elettrodi nel cranio, di maiali usati per cronometrare il tempo necessario a morire in variegate situazioni. Doveroso, si dirà: la scienza non può permettersi sdolcinature. Ma nemmeno negli interventi nei vari dibattiti televisivi succede mai di cogliere espressioni di dispiacere né vago disagio, che non sia quello provocato da domande imbarazzanti.
Certo, il distacco emotivo, la separazione dell’affetto è condizione imprescindibile per un lavoro tecnicamente corretto: l’autocontrollo, che presuppone gestione delle emozioni, è tratto necessario così per il medico che deve imporre un percorso doloroso al suo paziente, come lo può essere a volte per un genitore che deve aiutare un figlio in difficoltà: ma in questi casi la capacità di tenere a bada l’emotività trova il proprio senso nel perseguimento del benessere dell’altro, che richiede non di abolire, ma di controllare le proprie reazioni. Nel caso della vivisezione tutto si può sostenere tranne che sia pratica condotta nell’interesse dell’animale coinvolto. In assenza di outing al riguardo da parte dei vivisettori, non resta che rifarsi a spezzoni di filmati, rigorosamente clandestini e quindi rari, girati nei laboratori: mostrano beagle gettati violentemente e rabbiosamente contro il muro perché, nonostante la loro assoluta mitezza, provano a ribellarsi all’ago troppo grosso forzato nella vena; mostrano ricercatori prendersi una pausa di riposo per caffè e quattro chiacchiere mentre il coniglio sul tavolo è lasciato a “metà lavoro”, tanto di lì non si muove; mostrano la ricercatrice sorridere alla videocamera mentre muove gli arti inerti, a mo’ di bambola, alla scimmietta inebetita, con lo sguardo perduto, la testa attraversata dalla ricucitura di una ferita che la percorre in tutta la sua lunghezza.
Insomma un quadro che definire empatico non è proprio possibile. Di certo la frequentazione quotidiana con la sofferenza induce un progressiva desensibilizzazione: il cervello è plastico, ogni esperienza si coniuga con l’attività neuronale e crea nuove connessioni: gli avvenimenti che ci coinvolgono non vanno perduti dal punto di vista psicologico ed entrano a fare parte del nostro mondo psichico; è conseguente che muoversi in un universo di dolore e disperazione comporta plasmarsi su tale esperienza, perdere sensibilità ed indurirsi. Questo mentre un altro meccanismo entra prepotentemente in gioco: la capacità di dissociazione, di separare cioè aspetti della propria realtà interna da altri che risulterebbero incongruenti con il senso della propria identità. La riprova più eclatante è fornita dai criminali nazisti, che sappiamo conducevano una vita “normale” al di fuori del loro ruolo. Un esempio per tutti: Franz Stangl, responsabile, quale comandante del campo di sterminio di Treblinka, della morte di novecentomila persone, continuò ad avere comportamenti da padre attento e affettuoso delle sue bambine quando “in licenza”, e da ottimo capo famiglia, buon vicino di casa e gentile collega di lavoro, per tutti gli anni che passò da libero cittadino dopo la guerra, prima del suo arresto nel 1967 (“In quelle tenebre”, Gitta Sereny, Gli Adelphi). Così ci si deve fare una ragione quando si vedono i vivisettori in abiti borghesi, compiti e competenti difendere graziosamente il loro lavoro: la dissociazione è in atto alla grande.
Restano a mio avviso aperte questioni di grande respiro: vale a dire il fatto che ancora agli inizi sono gli studi sulle conseguenze della violenza legalizzata, categoria a cui la vivisezione appartiene come del resto vi appartengono per esempio a livello intraspecifico la guerra, la pena di morte, regimi carcerari di intollerabile ferocia, certe forme di punizioni corporali o psicologiche sui bambini, e, a livello interspecifico, la macellazione degli animali, la caccia, la pesca, l’addestramento degli animali nei circhi, il loro uso nelle sagre. In tutti questi casi, e in molti altri ancora, la violenza viene disconosciuta come tale proprio in quanto legale, condotta secondo regole stabilite, in luoghi stabiliti, da persone stabilite. Per inciso basterebbe pensare agli stessi atti compiuti in contesti diversi perché a tutti risultasse chiara la loro inaccettabilità.
Non bisognerebbe dimenticare che le regole che, in periodi storici specifici, le società si danno risultano spesso del tutto relative, palesemente scollate dalla morale se esaminate in epoche o anche solo in climi culturali mutati: ci vuole tempo, purtroppo, perché quello che pochi illuminati intuiscono, entri nella coscienza della maggioranza delle persone. Basta pensare alle tante ignominie che nel corso della storia sono state compiute legalmente, secondo riti e leggi: vogliamo pensare ai roghi delle streghe, vale a dire di donne e ragazzine troppo belle o troppo intelligenti o troppo indipendenti per essere tollerate dai maschi dominanti, bruciate vive sulla pubblica piazza con la benedizione dei tribunali e nell’entusiasmo della folla? Siccome agiva in ossequio alle norme vigenti, chi quei roghi accendeva e chi ad essi plaudeva deve godere del nostro rispetto?
Gli studi, dicevo, sulle conseguenze della violenza legale non sono ancora debitamente diffusi e per altro il gran numero di variabili che comportano li rende per forza di cose estremamente complessi: difficile per esempio capire esattamente come incida sulle persone vivere in uno stato in cui vige la pena di morte, con il correlato di orrori che comporta. Ma alcuni dati cominciano ad emergere; una ricerca del 1988 per esempio dimostra alla base della violenza diffusa nella società americana l’intreccio in quella cultura di “ineguaglianza economica e razziale, punizione corporale dei bambini, sport violenti, pena capitale e altre forme di violenza legittimata”. La psichiatra Felicity de Zulueta nota che “In Svezia dove l’abolizione dell’uso di schiaffeggiare i figli è in vigore da dieci anni, nessun bambino è morto per l’effetto dell’abuso fisico, laddove nel Regno Unito, dove le punizioni corporali sui bambini sono ammesse, due bambini alla settimana muoiono a causa di abuso e trascuratezza” (“Dal dolore alla violenza”, Felicity De Zulueta, Raffaello Cortina Editore): si aprono nuovi orizzonti di studio e di comprensione, dove restituire il significato di crudeltà a qualsiasi atto che abbia come conseguenza il male inflitto coscientemente ad un altro essere vivente, indipendentemente dalla specie a cui esso appartiene e dal motivo per cui viene compiuto.
Per concludere, la vivisezione, pratica estrema di prevaricazione della specie umana su altre e di un individuo umano su un individuo non umano, imprigionato, immobilizzato, torturato e normalmente ucciso, si situa all’interno di rapporti di violenza, che sollecitano considerazioni connesse al tema generale dei diritti e a quello anche più privato della compassione, dell’empatia, del rispetto, così fondamentali in ogni relazione e imprescindibili ai fini di una pacificazione, ora così tremendamente lontana, degli abitanti di questa terra.
Resta attuale l’invito di Richard Wagner al vivisettore perché guardi non all’interno dell’animale che lui ha sventrato, ma piuttosto nei suoi occhi: “Se guardasse ancora più a fondo, gli parlerebbe la sublime tristezza della natura per la sua esistenza piena di tormento, poiché lì dove egli scherza con la scienza, l’animale prende la cosa sul serio”, la prende sul serio fino al punto, alla fine, di abbandonare, inconsolato, il suo respiro su un mondo dove avrebbe dovuto poter vivere e morire secondo le regole della natura e il ritmo delle stagioni, e ha invece dovuto farlo secondo quelle stabilite da chi sciaguratamente ha preso il comando.

www.annamariamanzoni.it
psicologa e scrittrice